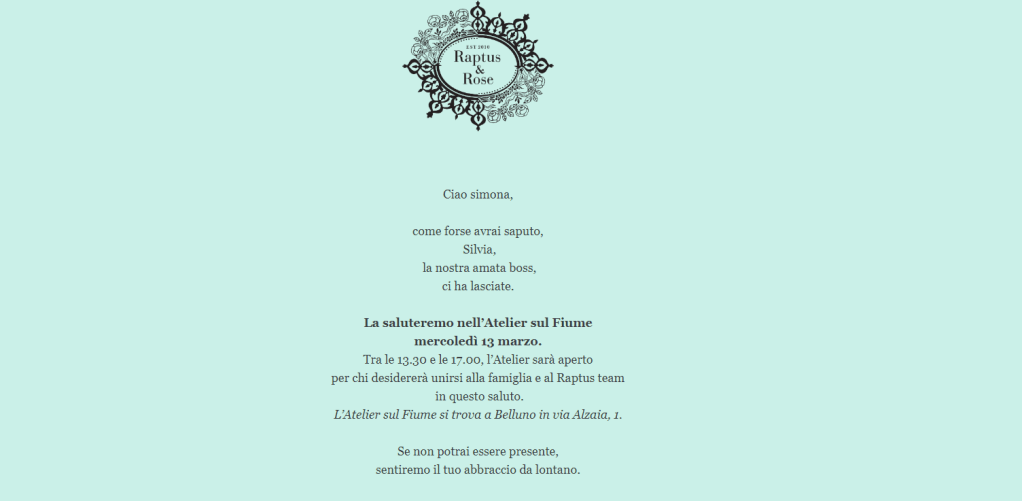Per fortuna non se ne fece di niente. Nel senso che non ci fu bisogno che il Caso Umano mettesse a disposizione il “suo” appartamento per la famiglia canina, né tantomeno fu necessario che si trasferisse da me per qualche giorno.
Non riesco nemmeno a immaginare quali sarebbero potuti essere gli effetti di una soluzione del genere.
La vita procedette tranquilla, si fa per dire, nell’attesa che il Caso Umano trovasse finalmente una sistemazione, più o meno definitiva, che le permettesse di lasciare libera la casetta.
Ormai speravamo che quel giorno si avvicinasse più in fretta possibile.
Dopo la mia serata a teatro con le amiche il Caso Umano, ovvero la Tipa della Conchiglia Sbriciolata, aveva in programma di assentarsi per qualche giorno.
La sera prima della partenza, mossa da un pericoloso spirito di compassione, bussai alla sua porta. In mano avevo una borsa di paglia foderata di tessuto bordeaux, che a sua volta conteneva un maglioncino d’angora dello stesso colore e una copia di un libriccino scritto da me.
Lei era una che faceva molti regali. Mi pareva giusto ricambiare.
Ma soprattutto ero dispiaciuta per il suo disagio. Il fatto che io continuassi a trascorrere le giornate portando avanti il mio lavoro, pensando a mamma, alla casa, ai miei interessi, anziché metterla al centro del mondo, riusciva addirittura a scatenarmi dei sensi di colpa, per quanto cercassi di oppormi con tutta me stessa. Per questo decisi di fare un passo in avanti, nella speranza che si potesse creare un certo equilibrio, anche solo per affrontare il tempo che avrebbe trascorso ancora lì.
Il bubbone scoppiò il giorno dopo, una mattina di metà marzo, dopo un temporale da tregenda. Per colpa di un sacchetto di spazzatura.
Intorno alle 8 ricevetti un messaggio dal Caso Umano che mi informava di aver lasciato il sacchetto della spazzatura davanti casa perché, muovendosi a piedi e con una valigia, data la pioggia fortissima, non ce la faceva a portarlo con sé.
Che problema c’è? risposi. Ci penso io.
Poi però, quando andai a prenderlo successe questo. Tirai su una busta e mi si rovesciò tutto a terra. Il “sacchetto” consisteva in un accumulo di sei o sette buste per l’immondizia contenenti ogni genere di rifiuto, dall’umido alla plastica, al vetro, tutto mischiato, tutte aperte.
Le scrissi un messaggio cercando di stare più neutra possibile.
Lei cominciò subito a giustificarsi.
Sai che non sapevo come differenziare? Infatti te lo avrei voluto chiedere.
Naturalmente ne avevamo parlato, tanto che lei mi aveva detto di avere la propria tessera per i cassonetti al che io ripresi quella che lascio a disposizione degli ospiti. Poi, che vuoi chiedere? Per differenziare non ci vuole una scienza. Specialmente se in casa ti ritrovi una serie di contenitori con le etichette carta, plastica e vetro, oltre al bidoncino dell’umido. Più il normale secchio per l’indifferenziato, naturalmente.
Purtroppo ebbi la conferma, un’altra, che probabilmente non capiva e sicuramente non ascoltava. Però si stizzì molto e, ritenendo di essere stata ripresa su una cosa di cui non aveva colpa, cominciò a buttarmi addosso tutto quello che riteneva non andasse nell’appartamento “dove era costretta a stare”. Un tubo del bidet rotto (segnalato la sera tardi e riparato la mattina dopo), una doccia che non funzionava perché, essendo protetta solo da una tenda, la prima volta che l’aveva usata aveva allagato il bagno, lo scarico della lavatrice nel water. Gli insetti. Un fornelletto a gas invece del piano cottura.
Nell’appartamento per il quale le avevo chiesto una cifra simbolica, messo a sua disposizione nello spazio di un giorno e per il tempo che le serviva, una settimana, cinque o sei, rinunciando se necessario anche agli affitti di Pasqua, e senza chiedere anticipi, caparre o altro.
Ero senza parole.
Però cominciai ad arrabbiarmi. Le dissi che la trovavo offensiva, oltre che ingiusta. E lei cominciò a cancellare tutti i messaggi in chat.
Quella mattina feci due cose. Indossai un paio di guanti in lattice e cercai di differenziare la sua immondizia, per quanto era possibile. Poi le dissi chiaramente quello che pensavo di lei e che il mio unico errore era stato quello di aiutarla in modo disinteressato.
Fra tutte le stupidaggini che aveva scritto, c’era qualcosa che mi aveva colpito più di tutto il resto. Lo scarico della lavatrice nel water. Chi può considerare un problema una cosa del genere? Specialmente in una casa di passaggio.
Presi la chiave di scorta e andai a dare un’occhiata. Riuscii ad arrivare fino in bagno, dove l’occhio cadde sulla seggetta del water, spaccata, ancora appoggiata sopra al tubo di scarico della lavatrice. Cioè, veramente credeva di doverlo lasciare lì per sempre e non soltanto quando azionava la macchina? Omiodio.
Purtroppo vidi anche in che condizioni erano la doccia, il lavandino, il famoso bidet con il tubo che perdeva. Macchie dense e scure, capelli ovunque, bustine aperte di cosmetici gettate qua e là. Asciugamani completamente fradici buttati a terra…
In camera? Il disastro. Quando era arrivata aveva chiesto un posto dove poter tenere i suoi valigioni e il ragazzo che le aveva fatto il trasloco si era arrampicato sulla scala fino a un soppalco. In quel momento scoprii che lei se li era riportati giù uno per uno, saturando ogni spazio vuoto della stanza. Tra il letto e la parete nord aveva messo anche lo stendino, aperto e carico di panni. Sul tavolinetto un megatelevisore, una copia della Bhagavadgītā, vestiti ovunque, biancheria, fermagli per capelli.
Ebbi una visione. Lei, triste e solitaria, seduta sul letto con l’unico conforto di quei valigioni stretti tutti intorno. E io che pensavo potesse starsene serena almeno per un po’.
Non era cosa da lei.
Dall’armadio a muro, lasciato aperto, vidi spuntare una specie di lampadina da notte, due sfere di plastica bianca l’una sull’altra, come un otto, e un piccolo schermo nero stondato sulla parte superiore.
Non ci feci troppo caso, mentre scattavo qualche foto di tutto quel disastro.
(6)